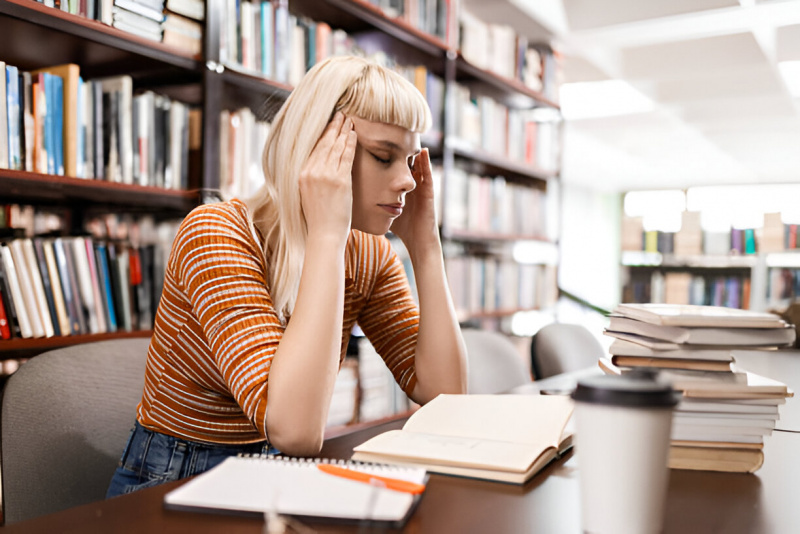Benessere psicologico degli studenti universitari italiani: sfide, rischi e soluzioni
Il passaggio dalla scuola superiore all'università coincide con il delicato ingresso nell'età adulta. In questo periodo le richieste accademiche, i cambiamenti sociali e l'incertezza per il futuro possono mettere a dura prova l'equilibrio mentale. Non stupisce, quindi, che proprio tra i banchi delle facoltà emergano con frequenza elevata forme di stress, ansia, depressione e altri disturbi psicologici.
Quanto è diffuso il disagio?
Le stime nazionali parlano chiaro: circa tre studenti su quattro soffrono di stress (oltre il 70 %), sei su dieci di ansia (circa il 62 %), quattro su dieci di depressione (circa il 42 %) e quasi due su tre presentano disturbi del sonno (circa il 64 %). Il rischio suicidario coinvolge poco più del 6 % degli universitari. In altre parole, più della metà della popolazione studentesca sperimenta una qualche forma di malessere psicologico rilevante.
Principali fattori di rischio
Biologici: presenza di malattie croniche e familiarità per disturbi psichiatrici rendono l'equilibrio emotivo più fragile;
Genere femminile: le studentesse mostrano tassi più alti di ansia e depressione;
Orientamento sessuale non eterosessuale: chi si identifica come gay, lesbica o bisessuale subisce spesso stigma e isolamento, con impatto sul benessere;
Difficoltà economiche: rette, affitti e costi di vita aumentano il carico di stress;
Vita fuori sede: lontananza da famiglia e rete amicale abituale può accentuare la percezione di solitudine;
Dinamiche familiari conflittuali: partecipare a tensioni o essere coinvolti in separazioni turbolente accresce la vulnerabilità;
Tratti di personalità disfunzionali: elevata negatività, perfezionismo e difficoltà a riconoscere le emozioni (alessitimia) favoriscono l'insorgenza di sintomi;
Pandemia da COVID‑19: l'improvvisa didattica a distanza, l'isolamento sociale e la paura del contagio hanno amplificato i livelli di stress e ansia.
Fattori protettivi
Non mancano però gli elementi che aiutano a prevenire o a mitigare il disagio:
Resilienza individuale, ossia la capacità di riorganizzarsi dopo un evento negativo;
Supporto sociale da parte di familiari, amici, docenti e tutor;
Ambiente universitario inclusivo, privo di discriminazioni;
Attività fisica regolare e stile di vita bilanciato (sonno adeguato, alimentazione sana);
Coping funzionale: tecniche di problem solving, meditazione, auto‑efficacia;
Interesse intrinseco per il proprio corso di studi, che alimenta motivazione e soddisfazione.
Ripercussioni sulla vita quotidiana e sul rendimento
Il disagio psicologico non riguarda solo l'umore: incide su concentrazione, memoria, motivazione e, di conseguenza, sulla performance accademica. Studi su corsi sanitari mostrano che l'ansia può impennarsi prima degli esami clinici; tra gli studenti di medicina è documentato l'uso di sostanze stimolanti (caffeina ad alto dosaggio, modafinil, metilfenidato) per sostenere ritmi di studio serrati, con il rischio di aggravare lo stress. A lungo termine, il malessere può tradursi in abbandono degli studi, conflitti interpersonali e compromissione della salute fisica.
Strategie di intervento
A livello individuale:
coltivare routine sane (sonno regolare, pause attive, alimentazione equilibrata);
praticare tecniche di mindfulness o respirazione per gestire l'ansia;
stabilire obiettivi di studio realistici, spezzando i compiti complessi in fasi gestibili;
chiedere aiuto tempestivamente a professionisti quando compaiono segnali di disagio.
A livello universitario:
potenziare i servizi di counselling psicologico (anche online) gratuiti e facilmente accessibili;
formare docenti e personale a riconoscere i campanelli d'allarme;
creare spazi di ascolto peer‑to‑peer e gruppi di auto‑mutuo‑aiuto;
promuovere programmi di educazione alla salute mentale fin dai primi semestri;
favorire attività sportive e culturali che rafforzino la cohesione di comunità.
A livello di politiche pubbliche:
sostenere economicamente gli studenti in condizioni di fragilità attraverso borse di studio e alloggi a prezzi calmierati;
integrare il tema della salute mentale all'interno delle strategie nazionali per il diritto allo studio;
finanziare interventi di terapia cognitivo‑comportamentale e programmi di prevenzione del suicidio rivolti ai giovani adulti.
Conclusioni
I dati mostrano che il malessere psicologico tra gli universitari italiani è un fenomeno ampio e complesso, alimentato dall'intreccio di fattori personali, sociali e ambientali. Riconoscerne le dimensioni e intervenire con approcci multilivello non è solo una questione di benessere individuale, ma un investimento sul capitale umano del Paese. Puntare su prevenzione, sostegno e ambienti accoglienti significa favorire studenti più sani, motivati e pronti a contribuire alla società di domani.
FONTE